Filosofia pratica e cultura
Le riflessioni che seguono sono emerse a conclusione della nona edizione della Scuola di filosofia di Trieste che, fin dall’inizio, ospita tre laboratori di pratiche filosofiche. Il laboratorio coordinato da chi scrive aveva per titolo Le solitudini del femminile.
Cosa significa fare cultura?
È una domanda a cui è piuttosto difficile rispondere, essa attraversa la nostra società nel suo insieme: dalla domanda sul ruolo dell’intellettuale oggi, a quello della scuola e delle istituzioni, fino al senso del dominio economico sulle vite; si tratta insomma di una questione che si pone ovunque ci troviamo, in ogni luogo e contesto che meritino di essere investiti da una domanda di senso. Non occorre porci le domande ultime, ma semplicemente quelle contingenti e riferite a un particolare contesto: che senso ha andare a scuola, che senso ha impegnarsi nel luogo di lavoro, che senso ha il mio matrimonio e così via. La crisi dell’intellettuale, come rappresentante di quella attività che dovrebbe fornirci le coordinate per assicuraci l’orientamento nella selva del senso, è stato il primo ad andare in crisi già a partire dalla metà del XIX sec.
Non è certo sufficiente la trasmissione di un sapere teorico o la conoscenza di un determinato contesto culturale per garantire che si stia facendo cultura.
Per Hannah Arendt, ad esempio, parlare di qualcosa a nessuno più che un attività culturale, si configura come un’attività violenta. Se assumiamo questo semplice dato iniziale, possiamo concordare che fare cultura e praticare la violenza sono, se non del tutto, ampiamente antitetici. Ovviamente quel “nessuno” non indica un’assenza di uditorio o di lettori o di altre forme di socializzazione, ma è un discorso che non intercetta nessuna domanda, un discorso fatto per nessuno, appunto, che cade su un terreno privo di corrispondenze e di domande urgenti per l’altro.
In generale chi parla, o è chiamato a vario titolo ad esprimersi in pubblico, è esposto a questo terribile pericolo di essere il generatore di una violenza impalpabile e di difficile definizione, ma, cionondimeno, chiaramente percepita. Chi vuole comunicare si trova quindi nella posizione impossibile di trasmettere qualcosa, un’eredità o un sapere di qualche tipo; trasmettere la vita quindi o addirittura donare la vita in forma di pensiero-parola.
Fare cultura è allora un momento ampiamente impossibile da pianificare o da prevedere. Dobbiamo accettare che questo agire, in cui un segno dovrebbe essere lasciato, una traccia, riposi nella dimensione dell’imponderabile e dell’eventualità.
Fare cultura è innanzitutto una pratica che entra in relazione con altre pratiche che si danno per acquisite e per le quali non è necessario un ripensamento. Se per eccesso dovessimo sempre ripensare da capo le pratiche in cui siamo immersi, entreremmo in una dimensione paralitica, in un’immobilità impotente. La paura di questa impotenza è ciò che però ci tiene lontani dalla possibilità di fare cultura. Questo dimensione paurosa paralizza il pensiero e l’immaginazione, motivo per cui ciò che essa vuole evitare è ciò che esattamente produce, anche se si manifesta nella figura opposta a quella che essa prevedeva. L’attivismo, non sto dicendo ovviamente niente di nuovo, è questa forma paradossale di impotenza, in cui estrema attività ed estrema passività coincidono.
Fare cultura, quindi, implica anche un dosaggio appropriato, che è possibile somministrare solo se si è in grado di concepire la necessità di non totalizzare la dimensione del fare e allo stesso tempo di capire che l’esercizio intellettuale è, benché nella giusta dose, appunto, un veleno necessario. Il pharmakon è proprio questo: un provvedimento che cura e che è, allo stesso tempo, un veleno.
Le pratiche acriticamente messe in atto non fanno, ma sono cultura e, in quanto tali, tracciano quella cosa sempre di difficile definizione che chiamiamo identità.
Fare cultura è una pratica o un insieme di pratiche che si inseriscono in altre pratiche, modificandole. Senza l’aspetto liturgico e anche ripetitivo delle pratiche della convivenza, nessuna cultura si potrebbe dare. In queste liturgie ciò che prende corpo sono le relazioni di potere tra i soggetti e possiamo dire, forse con qualche forzatura, che cultura è proprio l’assetto di queste relazioni di potere, della sua spartizione insomma, e dei modi in cui tale spartizione viene vissuta e riprodotta.
Riprendendo la lezione foucaultiana sulla microfisica del potere, dobbiamo segnare qui un punto: il potere non è qualcosa che qualcuno assume in sé a scapito di un altro che ne sarebbe privo, o peggio il segno di un male da mondare; esso piuttosto è la stoffa stessa delle relazioni, senza la quale esse semplicemente non si costituiscono. Fare un concreto discorso sulla giustizia prevede una certa lucidità in merito.
Questa spartizione del potere qualifica una determinata cultura, mentre il farla significa incidere con le proprie pratiche in quelle istituite al fine di alterarne almeno di un pochino il corso.
La pratica filosofica, che per brevità ora riassume in sé la distinzione tra consulenza e pratiche filosofiche, si pone all’interno di questo rapporto contraddittorio tra pratiche istituite e pratiche istituenti. Com’è ovvio, in questo ambito il rischio di fallimento è altissimo, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui ogni pericolo di alterazione del sistema viene, in tempi brevissimi, neutralizzato, essendo in grado di assorbire in sé ciò che potrebbe apparire come una difformità rispetto alle risposte istituzionali, sociali o individuali previste.
La pratica filosofica si trova all’incrocio di svariate tendenze di pensiero, senza, di fatto, sposarne alcuna. È una sorta di proteo in grado di assumere le forme più diverse e di rilanciare continuamente l’ordine del discorso che viene perciò rimesso in discussione incessantemente. Essa rifugge quindi dalla fissazione teorica.
Se prendiamo a esempio la Scuola di filosofia di Trieste, che ogni anno ospita, accanto ai momenti espositivi e frontali di un tema, anche laboratori di pratiche filosofiche, possiamo dire che queste ultime rappresentano, oltre che un importante complemento all’esposizione più teorica di determinati temi, anche un momento di contraddizione e di crisi strutturale interno alla Scuola stessa.
L’attivazione delle pratiche filosofiche all’interno della Scuola costituisce quindi un momento critico rispetto a quella fissazione che, in ogni caso, è necessaria e inevitabile.
L’ importante, qui, è il fatto che quella critica non si svolge sul piano teorico, ma attraverso una pratica i cui protagonisti sono questa volta i corsisti; i laboratori sovvertono, in un certo senso, il rapporto di potere che viene instaurato nelle esposizioni frontali. Se in queste prevale il riferimento ad un autore o ad un tema, la posizione di chi ascolta incarna per lo più la figura del servo e della passività. La verticalità del rapporto è inevitabile: chi si trova a parlare ex cathedra necessariamente assume il ruolo di un soggetto supposto sapere, per dirla con Lacan. Questo fatto non può essere criticato nel senso di mettere in atto il tentativo di annullare l’effetto di supposizione. Esso può solo essere controbilanciato da altri momenti. Anche se l’eloquio di chi espone un tema può essere più o meno caldo, più o meno coinvolgente, la posizione apicale di chi parla non può essere rimossa. Anzi va messo in chiara evidenza che proprio quando l’eloquio è più virtuoso, più coinvolgente, quando si spinge verso un lato immaginativo e figurale della trattazione di un tema, l’effetto di padronanza è maggiore. Proprio nel tentativo di sfuggire ad una troppo stringente e concettualizzata trattazione del tema, chi parla inizia ad assumere una dimensione magistrale, di maestro insomma.
Va tenuta ben presente tale questione che è di importanza fondamentale: la dimensione suggestiva e seduttiva del discorso passa attraverso la capacità di navigare in un mare in cui la metafora e l’immagine rappresentano l’onda che rende possibile la navigazione stessa.
L’estremo versante di questa pratica è la predica ecclesiastica che è in grado di non dire nulla di intellegibile, ma di evocare, utilizzando le immagini sottese dai dogmi confessionali, una fascinazione e una seduzione senza pari. È senza dubbio un eccesso che la filosofia non può certo far suo, ma che, nonostante ciò, orienta lo sguardo ad un ben determinato problema. Il discorso filosofico non può – e non deve – rimuovere questo rapporto all’immagine, ma deve mantenerla all’interno di un legame con i vissuti concreti della propria ed altrui esistenza.
L’eccesso di concettualizzazione astratta depotenzia chi parla, cosa che sembra permeata da una certa democraticità del discorso, perché vorrebbe fare a meno della suggestione, ma il prezzo che si paga per questa supposta rinuncia è un più o meno radicale distacco da chi ascolta.
Questo riferimento al vissuto e alla dimensione esistenziale del discorso è proprio quanto caratterizzerebbe l’andamento della pratica filosofica. Essa, come anticipato prima, è un crocevia di suggerimenti e, a volte, anche di suggestioni riprese da ben determinate teorie filosofiche, dalla letteratura o da altre forme espressive.
I riferimenti teorici a cui le pratiche filosofiche attingono provengono da discipline di pensiero che hanno tutte, in modi diversi, reintrodotto nella filosofia l’idea di esercizio. E l’esercizio è appunto una pratica, prima ancora di poter essere descritto in una dimensione teorica.
Così ad esempio la fenomenologia, inaugurata da Husserl, è un aspetto fondante delle pratiche filosofiche. Aut Aut ha dedicato a questo tema il numero 390, intitolato Il gesto fenomenologico.
Husserl appare come un sintomo nell’orizzonte delle questioni che stiamo cercando di affrontare: il titolo del n° 390 di Aut Aut rinvia alla complessa vicenda della fenomenologia che ha assunto nel tempo anche l’aspetto di un apparato teorico compattissimo. Così gli studiosi possono cadere nella trappola di assumere il lessico fenomenologico come una costellazione di concetti all’interno della quale ragionare, perdendo di vista il rapporto vivo con quella che è stata in grandissima parte l’esperienza vissuta del suo iniziatore. A rigore, questa la scommessa del n° 390, non si dà fenomenologia se non rifacendola ogni volta da capo, l’immer wieder husserliano, appunto. L’esperienza fondata sull’esercizio dell’epochè è quindi soggettiva senza essere però soggettivistica.
Questa pratica della sospensione del giudizio rimane, almeno a mio avviso, centrale nella pratica filosofica in cui il momento del conoscere si confonde con il momento etico. Per semplificare: l’esercizio delle pratiche filosofiche non prevede mai, salvo casi eccezionali, la smentita dell’interlocutore, in quanto anche la più bizzarra affermazione o posizione teorica espressa rimanda ad una sottostante logica del discorso che è il vero obiettivo della pratica. Insomma il come è molto più importante del cosa e vale la pena ricordare che anche il tema del come è un altro asse portante della pratica fenomenologica. Come un determinato contenuto si dà, è cosa più significativa del rimando al cosa esso esprime.
In altri termini le pratiche filosofiche sono caratterizzate da un’inversione di priorità: se il cosa, in termini linguistici rimanda al significato, il come ha maggiore affinità col significante. Il momento teorico diviene meno importante rispetto ai modi in cui esso viene espresso per mettersi a disposizione dell’altro.
Ci troviamo così in prossimità di altre due forme di esercizio che attraversano le pratiche filosofiche: la decostruzione e la psicoanalisi. La prima come una pratica che si apre alla genealogia del nome e quindi ai costrutti teorici che intorno a esso storicamente si sono formati; la seconda come clinica ed esercizio di attenzione in cui il discorso si fa sintomo.
La Scuola di Filosofia, che costituisce lo sfondo concreto di queste riflessioni è attraversata esattamente da questi tre discorsi: quello fenomenologico, nella versione maggiormente legata al pensiero debole, quello psicoanalitico, nella fattispecie lacaniano, e quello decostruttivo che ha assunto principalmente l’aspetto di una storia dei sistemi di pensiero.
La pratica filosofica che, quindi, coincide con il movimento stesso della Scuola, raccoglie questi tre alvei discorsivi che, come affluenti, alimentano non tanto un fiume, i cui argini sarebbero ben individuabili, ma piuttosto un mare del quale è difficile stabilire i contorni.
La pratica filosofica non ha quindi posizione, manca di chiarezza, essa non è istituita nel senso di un’appartenenza certa ad una determinata tradizione di pensiero, ma si trova, in un certo senso, sempre all’inizio, in una condizione istituente.
Essa riprende da capo ogni qualvolta l’altro prende parola; l’esplorazione riprende dal campo base per inoltrarsi in un territorio che potrà rendersi visibile solo procedendo nel suo attraversamento.
Gli ambiti filosofici e le tradizioni discorsive che ispirano le pratiche filosofiche ci hanno insegnato in modi diversi e sotto angolature specifiche che il discorso vero non può essere un oggetto, ma un evento che si produce storicamente, essendo sottoposto al tempo e al divenire. È esso stesso il proteo goethiano, il delfino che si confonde con il flusso delle acque dalle quali è anche sostenuto. Questo aspetto dinamico e genetico inquieta la filosofia anche nel suo aspetto di pratica.
Le pratiche filosofiche dovrebbero quindi assumere in sé la natura di un discorso che continuamente prende congedo, prive come sono di un nocciolo teorico di riferimento.
Questo fatto, che ritengo di primaria importanza, può generare alcuni fraintendimenti, forse inevitabili, rispetto al ruolo e al modo in cui le diversi correnti del pensiero filosofico vengono assunte nelle pratiche stesse.
Per alcuni il riferimento può essere la decostruzione di Derrida, per altri la filosofia del tu di Buber e così via; il rischio è quello di prendere e utilizzare tutto ciò come un arnese, assumendolo acriticamente nell’esercizio del dialogo con l’altro.
Al contrario ritengo che la tendenza dovrebbe proprio essere quella di stare su più fronti teorici e di invertite la rotta secondo cui l’altro, nello specifico l’autore di filosofia, è un pezzo di discorso che mi serve.
Ad una ipo-teoresi ci si dovrebbe orientare ad una iper-teoresi, da perseguire non tanto per presentarci ferrati, ma per mostrarci quanto più possibile orfani di pensiero.
Possedere le coordinate di molti discorsi non significa avere una bussola più efficiente per attraversare un territorio, ma, al contrario, è la garanzia della nostra ignoranza e del fatto certo di dover sostenere il peso dell’incertezza. Essa si palesa sempre dove c’è profondità, mentre la certezza si offre facilmente ad un pragmatismo delle pratiche.
In questo senso discriminare tra verità e simulazione non è cosa facile. Quel soggetto che si assume il compito di allestire lo spazio del discorso in quale misura si trova lì, in carne ed ossa, e quanto invece si rappresenta attraverso comodi orientamenti di pensiero? Il fenomeno di alienazione di un reale esercizio fenomenologico in una teoria fenomenologica, che viene continuamente smontata e rimontata, ci indica quale sia il pericolo di cui sto parlando. Quello di Husserl è ovviamente solo un esempio che potrebbe essere moltiplicato per mille.
Dovremmo lavorare sodo per impedire quel fenomeno inquietante in cui il dialogo è condotto da un sapere nascosto, in cui il discorso che ci si pone di fronte è in realtà l’esito di un trucco da ventriloqui.
Si tratta, prendendo un prestito dalla psicoanalisi, del discorso del padre, anche se è un padre nascosto che si pone per di più in una posizione di smentita del proprio ruolo. Per questo penso sia un bene insistere sull’orfanotrofio come luogo di una libertà a volte anche violenta.
Apparentemente nella posizione opposta si trova chi afferma che ognuno di noi ha una propria filosofia. E di fatto proprio a questo mirano le pratiche filosofiche: a rendere esplicite le filosofie che ognuno cova nel silenzio di un discorso mai venuto alla luce.
Ma per farne cosa? Per sostituire ad esse altre filosofie più coerenti, migliori o più articolate? Non credo che questo sia l’obiettivo di quanto qui ci stiamo occupando. Il vero obiettivo è erodere progressivamente la parola “proprio”.
Le implicazioni di questo spossessamento da ciò che appare più proprio sono molteplici e in questo scritto non posso affrontarle estesamente.
Possiamo dire che affrontare l’assenza di proprietà del proprio pensiero ci avvia sulla strada di una certa impersonalità, un termine che ha dei debiti tanto con Deleuze che con Simone Weil. Impersonalità è non-personalità, è un modo d’essere in cui la soggettività stessa, condensata nella parola personalità, viene scossa e rimessa in gioco. Anche se non vogliamo, o non possiamo, seguire Simone Weil sulla china di una discesa mistica nell’essere del non-io, possiamo almeno contentarci di una provvisoria convivenza con un modo d’essere impersonale del mio proprio, che si affianca a quell’idea, mai del tutto estinguibile, di essere un soggetto pieno e personale. Ecco un fenomeno di erosione, una pulce in quell’orecchio abituato ad ascoltare solo le proprie filosofie private. Erosione non-violenta, nuove regole del gioco dell’identità, cautela insomma a sposare la prima cosa che ci sembra sensata o che ci viene in mente. Se una pratica filosofica raggiunge questo obiettivo basico in cui noi e i nostri interlocutori siamo realmente rimessi in gioco, allora abbiamo fatto qualcosa che non sta nel mondo dei sogni. Abbiamo fatto cultura. E questo accade perché nessuno che abbia messo piede nella stanza in cui persona e impersonale si guardano, ne può mai più uscire del tutto. Quella porta, una volta aperta, non può essere più richiusa.
La stanza in cui allora ci troviamo è uno spazio di comprensione di sé e perfino di compassione, ma è anche uno spazio di lotta e di violenza, poiché porsi in una condizione istituente implica inevitabilmente un momento di sovversione di un certo ordine istituito. Ma qui occorre essere chiari: non si tratta di una rivoluzione che ci proietterebbe in un pericoloso ed equivoco utopismo, ma innanzitutto di un sommovimento delle proprie pratiche discorsive e di pensiero rispetto alle quali ingaggiamo una lotta, poiché in esse non possiamo più riconoscerci a pieno.
Se quindi non vogliamo essere esportatori di violenza dobbiamo innanzitutto rivolgere una quota di essa verso noi stessi: da questa prospettiva, e credo solo da essa, ognuno di noi può fare cultura.
Niente di nuovo sotto il sole comunque: Impara a morire, non a uccidere è il monito dello stoico Seneca.
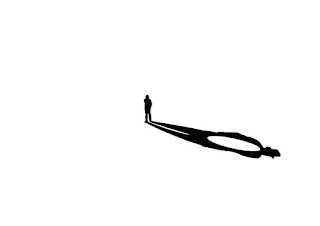


Commenti
Posta un commento